Quattro note (e quattro artisti) sulla pittura astratta
Dall’avvento dell’arte e del dibattito postmoderno, nei primi anni ottanta, il campo d’azione della
pittura astratta si è ridotto di molto, confinato spesso e volentieri alla sola seduzione decorativa 1.
La diade pittura astratta/Modernismo formalista infatti, – specifico formalista perché, come il suo
contraltare, anche il Modernismo ebbe molte e distinte vocazioni – era storicamente troppo salda e
connotata per non implicare la accorta emarginazione di entrambi i termini da parte del Postmodernismo,
persino nella sua versione più pluralista e filo-pittorica. Non si trattò di ragionare esclusivamente
per dialettiche oppositive, contro il moderno, bensì di aggirare l’effettiva impasse di quella diade,
che sembrò avere come proprio orizzonte teorico una destinazione escatologica, una compiaciuta
o rassegnata tendenza all’epilogo. Se ne inibirono così i sintomi per congedare un ingombrante
o paralizzante, a seconda dei punti di vista, progetto gnoseologico di auto-riflessività, di
puro-visibilismo, di ricerca del proprio campo di specificità, con annessi i suoi corollari ideologici.
Preme dunque, e anzitutto, sgomberare il campo da un falso problema ormai classico circa la pittura,
che si ripresenta con troppa frequenza e schematicità. Per contrapporsi a questa escatologia modernista,
si è spesso parlato di “ritorno alla pittura”, di resurrezione vera e propria dal fondo mitico del
passato, ammiccando a quella retorica che riserva spesso delle metafore biologiche per l’arte (evoluzione,
morte, rinascita, etc.). Ma a due decenni di distanza dalla “rianimazione” postmoderna possiamo
affermare con serenità quanto questa logica taumaturgica rientri nelle strategie, pur sofisticate, di marketing
e di creazione e stimolo della domanda. La liberazione e l’emancipazione prospettata dal Postmodernismo
pluralista, a conti fatti, è stata contingente e breve, non si è tradotta né nella gioiosa anarchia
annunciata, né in un progetto identificabile per le arti. Ci si è serviti della pittura (figurativa specialmente)
solo per ribaltare un paradigma, salvo poi accantonarla non appena la pluralità si è dimostrata più
promettente e – perché no? – più redditizia sul versante della postproduzione e del multimediale.
È su questo sfondo storico, pertanto, all’indomani del disincanto che un’impresa così massiccia di
rivalutazione della pittura ha lasciato dietro di sé, che si proietta la domanda e l’interrogativo d’oggi, circa la pittura astratta.
È un interrogativo, anzi più di un interrogativo, certamente fuori portata, vasto e complesso
sul quale però si può intanto raccogliere qualche annotazione pertinente senza cedere alla logica dei ritorni
e dei decessi, talvolta dettata da un lessico semplicemente ansioso di fronte alla crisi.
Innanzitutto, ci si può chiedere se per la pittura astratta sia ancora plausibile un ruolo all’interno di un qualche
progetto gnoseologico, di auto-coscienza o di auto-riflessione delle arti. Dopo che l’approccio analitico,
della linguistica e della semiologia, ha dovuto ricredersi su molti punti, specialmente davanti alle immagini, e
che i Visual Studies hanno reimpostato il problema nei termini di uno studio del visivo e dell’iconico, la pittura
astratta è sembrata marginalizzata da questa impresa e da queste indagini per sua carenza strutturale, anzi,
giocando con le parole, per un suo eccesso di struttura.
A tale quesito non può che sopraggiungere quello, forse salvifico, sull’effettiva validità di una separazione
così netta e individuabile tra figurazione e astrazione, o tra iconico e aniconico. Ed è un quesito ancor più
difficile al quale fa seguito, giocoforza, quello di individuare un ruolo, uno statuto della pittura non all’interno
delle suddivisioni disciplinari accademiche, dove mantiene una sua indiscussa trasmissibilità tecnica,
ma nel panorama più ampio delle arti contemporanee e della cultura dell’immagine.
È evidente che non esistano delle risposte chiare e definitive a questi interrogativi, ma un’opinione si può
intanto abbozzare, cercando di concatenare le considerazioni alle domande. Il legame tra analiticità e
astrazione si può rimuovere per la sua maggior parte proprio in virtù del fatto che una netta distinzione
tra astrazione e figurazione non sussiste più, e per moltissime ragioni, che vanno dalla meccanizzazione e
digitalizzazione delle immagini, per cui il problema diventa la loro mediazione e produzione, spesso al di
là della riconoscibilità del loro soggetto, alle teorie cognitive e filosofiche che riconoscono il ruolo attivo
dell’immaginazione dello spettatore nell’interpretare gli stimoli visivi. Grazie a questa ambiguità, ciò che si
può riscontrare mi sembra solo una residualità, un precipitato della pittura astratta, una bussola retrospettiva
che non delimita ma rintraccia una filiazione ogniqualvolta il processo di ottenimento dell’immagine
prenda, per così dire, il sopravvento sul controllo del risultato visivo, iconico o meno che sia.
Più in generale, mi sembra che la pittura debba accogliere, come tutti gli altri campi espressivi, la sfida di
non poter più affidarsi ad una ripartizione o gerarchia delle discipline artistiche circoscritta e definita, né di
poter far consolatorio appello ad una sua purezza, riconoscendo di avere una tradizione che l’ha resa aperta
all’intermedialità, all’interazione con altri media e linguaggi, come è stato per tanta parte della sua storia 2.
In questo orizzonte, dunque, gli artisti hanno la nuova libertà, di poter riflettere a partire da, sulla tradizione
astratta, assimilando e inglobandone il portato piuttosto che proseguendone, a tutti i costi, l’epopea.
Per non congedare, tuttavia, nemmeno l’intera tradizione analitica, vorrei almeno trarre insegnamento
da quanto ci ha detto Arthur C. Danto circa l’impossibilità di comprendere le arti contemporanee con un
approccio esclusivamente puro-visibilista. Ritengo oggi che ciò valga, particolarmente e paradossalmente,
per la cosiddetta astrazione pittorica e che proprio con alcuni luoghi disseminati della critica e della teoria
si possa cominciare a riallacciare i ponti e – per rimanere nella biologia metaforica – a intravedere una sostenibilità,
un’ottica di fertilità, vitalità e prolificazione della pittura.
Per questa ragione, recuperando qualche pagina della letteratura critica, ho ceduto alla pretestuosa simmetria<
– che proprio i quadri spesso ci fanno gradire – di rapportare alcune considerazioni, scritte alla
fuoriuscita dal Modernismo, a ciascuno dei quattro artisti in mostra.

Callum Innes, Untitled,1991, olio su tela, 30x25,3 cm.
Solco
Il primo luogo della critica che vorrei commentare approfonditamente è il celebre articolo di Rosalind Krauss,
che in piena vague semiotica riprese la nozione di “indice” (index) dalla teoria dei segni di Charles Sanders
Peirce. Come è noto l’indice accomunerebbe fra loro delle tipologie di segni apparentemente eterogenee, dalla
fotografia all’impronta, dalla bandiera che garrisce alla traccia del pennello, e per Krauss divenne un paradigma, in funzione decisamente anti-iconografica, delle arti degli anni settanta, dalla performance alla pittura.
Circa l’argomento che qui ci interessa, in questo articolo Krauss ebbe un’intuizione davvero germinale, annotando: «per quanto paradossale possa apparire, la fotografia è diventata progressivamente il modello operativo dell’astrattismo» 3. Ora, la mia impressione, circa questa sibillina affermazione, che ebbe senz’altro il merito di porre la questione pragmatica e percettiva delle arti in termini trasversali, intermediali, è che essa fu davvero germinale a causa delle sue latenti contraddizioni piuttosto che per la sua inattaccabile coerenza.
Se si svolge il basilare lavoro di comparare il testo alle immagini di questo articolo, se ne comprende il perché.
Nella sua seconda parte, esso commentava soprattutto le opere presenti a Rooms, una mostra al P.S.
1 di New York, un vecchio edificio scolastico diroccato, nel quale, fra gli altri, Lucio Pozzi aveva inserito
alcune tele astratte nei luoghi più disparati. La novità era che, per decifrare la composizione di queste tele,
non bisognava fare ricorso alla geometria o all’armonia compositiva, bensì agli indizi visivi provenienti dal
contesto architettonico: le tele proseguivano nelle colorazioni e nelle linee la diversità di conservazione
e tinteggiatura delle pareti dell’edificio, erano cioè sovrapponibili – e confondibili – con essa. Per Krauss,
queste opere erano un efficace esempio di indicalità, di connessione fisica, di un “effetto del lavoro” che
richiamava «un rapporto con il suo soggetto che è dell’ordine dell’indice, dell’impronta, della traccia» 4.
Ma se proseguiamo nell’osservazione di queste opere, la questione si complica, e di molto, divenendo
però un esempio che ci consente di passare dal particolare al generale. Innanzitutto, le tele di Pozzi non
erano ottenute con lo stesso procedimento fisico e chimico delle pareti, ma piuttosto esse simulavano
l’indicalità, essendo dipinte. Non si tratta qui, del solo rapporto di “secondità” indicato già da Peirce, per
cui ogni indice conterrebbe a sua volta un’icona, ma dell’insinuazione della mimesi del tutto inaspettata,
dell’instaurarsi di un rapporto di somiglianza intenzionale e tradizionale. Ancor più in generale, le tele
di Pozzi, con un’implicita dichiarazione ideologica o ironica, si mimetizzavano col lavoro del tempo e dei
verniciatori che segnava le pareti. Nel farlo, ricorrevano ad un altro tipo di indice (la pennellata) che
però si lasciava solo intravedere, a causa appunto del dispositivo mimetico in atto. Dunque le categorie
(simbolo, indice e icona) di Peirce cominciavano già a combinarsi in una tabella inestricabile e, forse,
inservibile 5.
La pittura, allora, è troppo complessa o il solo indice troppo semplice, affinché la riflessione resti allo stadio
in cui fu meritoriamente intuita. Il problema è troppo complicato anche per chi scrive, ma la mia opinione è
che esso riguardi più che altro il rapporto tra quanto della processualità dell’opera e quanto dell’attenzione
sul contesto l’artista (o il delegato critico) voglia incapsulare nel suo messaggio visivo o nell’apparato testuale
che l’accompagna (c’è da considerare poi che tale interpretazione, in ultima analisi, la possa e debba
compiere liberamente lo spettatore). Dunque si tratta di un problema squisitamente storico, che varia con
le epoche e le convenzioni visive e che, intanto, rivela una componente di inestricabilità e inagibilità intellettiva nel suo rapporto con l’iconico.
Un pittore come Callum Innes che ha spesso incluso l’indicalità, fisica o chimica, come agente del suo metodo, è un esempio di consapevolezza su quanto l’indice riguardi piuttosto il processo che il risultato visivo, che è spesso molto più aperto e ambiguo di quello che si preannunci. Eric de Chassey ha notato benissimo come in Callum Innes, oltre ad agire un “paradigma fotografico” ed una conseguente relazione con la memoria, sia in atto una poetica che non è “contro le immagini”, ma ne ha una profonda consapevolezza,
una sorta di stoica indifferenza per la loro eventuale apparizione, pur in un campo visivo che la tradizione
definirebbe comunque astratto 6.
Qui si incrina, dunque, uno dei punti di discrimine tra astrazione e figurazione, a patto che si intendano le immagini come le intende Gottfried Boehm nel suo Iconic Turn, ossia come un lavoro immaginifico dello spettatore e, in seconda battuta, come l’apparizione, per quanto minimale e non immediatamente figurativa, di una discontinuità su una superficie: «l’immagine è un’esigenza evidentemente radicata in profondità nell’uomo e sono sufficienti poche manipolazioni elementari affinché nel continuum uniforme del mondo materiale non
solo qualcosa “appaia”, ma anche, qua o là, qualcosa “si mostri”: all’occhio si riveli una visione che affiora
dalla materia, si dischiuda un senso. L’iconico si basa dunque su una differenza realizzata dal vedere» 7.
È su questa discontinuità, su questo solco, che è traccia ma anche assenza, affossamento ed evidenza, che
sopravvive quanto di inalienabile l’astrazione ha consegnato al lavoro di Innes.

Emanuele Becheri, vista dell’installazione alla mostra Nessuna paura, 2007,
Centro per l’arte contemporanea L. Pecci, Prato
Intermedio
Quando si tira in causa la differenza e la discontinuità del segno, non si può fare almeno un cenno al luogo filosofico nel quale tanta parte del rigore linguistico e semiotico degli anni sessanta e settanta è stato sussunto in un orizzonte decisamente più vasto ed ontologico. Che si condivida in toto o solo in parte – come il sottoscritto – l’impostazione di Jacques Derrida a cui mi riferirò, poco cambia: la sua rilevanza per le ricerche artistiche, per quanto mediata e sfumata, è stata decisiva, specialmente nella pittura. Ne la différance, il segno come “presenza differita”, che implica “l’essere presente” e il “presente che non si presenta” ha scardinato il taglio analitico più rigoroso della semiologia e con esso, nelle ricadute pittoriche, il suo corrispondente visivo, la praticabilità della pittura analitica ricondotta a dei termini, per così dire, rabdomantici, euristici e meno sistematici 8. La dismissione della pittura come sistema ha significato la nascita di un dispositivo mobile che, invece, sussume la pittura all’interno delle sue ricerche sia come origine di esse, sia come possibilità, fra le tante, della sua espressione.
Per tornare a Derrida, quello “stare per qualcos’altro del segno”, la “deviazione” che esso impone alla comunicazione e non solo, se la possibilità di una purezza e autoanalisi di ciascun medium salta, non può che avere un esito intermediale. Con intermedialità non si intende qui soltanto la possibilità di circolazione dei segni, da un medium all’altro, ma anche un postulato centrale della stessa teoria dei media, ossia il loro essere misti, mixed media 9. Intermediale è, in tal senso, preferibile a multimediale perché disambigua, palesando che non esistono dei media in purezza da combinare fra loro, e perché denota l’assenza di qualsiasi fascinazione per i nuovi media o nostalgia per i vecchi. Semplicemente tutti i media possono entrare in relazione fra loro, il presente adattarsi al passato e viceversa. E tale condizione va di pari passo con quella del segno: «se arriviamo ai media dal punto di vista della teoria dei segni, usando la triade fondamentale di Peirce, icona, indice e simbolo (segni per somiglianza, causa ed effetto o “connessione esistenziale”), scopriamo anche che non c’è segno che esista in uno “stato puro”, ovvero non esistono icone, indici o simboli puri» 10.
Se il cerchio teorico, fra media e segno, sembra chiudersi, in realtà sono le possibilità espressive e teoriche
a divenire pressoché inesauribili. La poetica e le opere di Emanuele Becheri ne sono la testimonianza
nel loro principio disegnativo, attorno al 2004, e nella loro ramificazione inarrestabile nel video, nella
vocalità, nella fotografia, nella scultura. Becheri muove dai primi disegni, tutt’altro che surrealisti, in
cui il controllo visivo è annullato con l’oscurità o la carta copiativa, poiché intuisce che l’elisione del
controllo visivo, nonché la crisi dell’intenzionalità e dell’autorialità, è la vera posta in gioco chiamata in
causa anche dalla condizione indicale, dato che tale condizione è di fatto presumibile, impura, simulabile
o involontaria. I video, che si vorrebbero opposti al disegno nella suddivisione temporale delle arti,
hanno invece lo stesso tipo di ricerca ed una maggiore maturità poiché permettono di far coincidere il
processo segnico con la significazione nel suo farsi e nel suo essere percepita, con tutte le ambiguità del
caso. Sono, a tutti gli effetti, dei dispositivi di differimento e differenziazione.

Ignacio Uriarte, Five drawings, 2011, penna e matita su carta, 63x92 cm
Tabula
Una delle differenze sostanziali fra il Modernismo e la sua fuoriuscita si può rilevare paragonando due cicli di quadri dipinti nella stessa epoca, nella stessa nazione, entrambi monocromi e denominati nello stesso modo: le Black paintings di Robert Rauschenberg (ma ancor di più le White paintings nel suo caso) si aprono al rumore contestuale, alla traccia che deriva dall’interazione ambientale, mentre quelle di Ad Reinhardt sono intonse e, in caso di danni espositivi, ridipinte e ripristinate nel loro stato originario di perfezione. Ma tra questi due cicli pittorici non esiste soltanto una differenza di apertura verso l’indicale, bensì anche l’accentuazione di una rottura, già preparata da Cézanne e dal Cubismo, dell’asse prospettico verticale che legava lo spettatore al quadro.
A registrare questo mutamento, proprio parlando di Rauschenberg, fu Leo Steinberg nel suo saggio dedicato
al “paradigma del pianale”:
«È ancora possibile appendere al muro i loro quadri, così come facciamo con le carte geografiche e i progetti architettonici, oppure quando inchiodiamo al muro un ferro di cavallo come portafortuna. Tuttavia, questi quadri non simulano più campi visivi verticali, ma “pianali” orizzontali opachi. Essi non dipendono dalla corrispondenza alto-basso relativa alla stazione eretta dell’uomo più di quanto dipenda da essa un giornale. Il piano pittorico inteso come “pianale” fa le sue allusioni simboliche a superfici rigide quali tavoli, pavimenti dello studio, tabelle, bacheche: insomma, ogni superficie destinata ad accogliere delle cose su cui siano sparsi degli oggetti, su cui siano registrati dei dati, su cui le informazioni possano essere accolte, stampate, impresse, in modo coerente o confuso» 11.
Il corollario di un’affermazione del genere, che dimostra anche quanto la critica possa tenere unite, nei suoi
momenti più felici, la prassi degli artisti e la percezione del pubblico, è che l’allestimento di un quadro non è
esclusivamente e ormai solo un’opzione verticale. Si tratta di una conseguenza, si badi bene, non di esclusivo
carattere formale poiché rimette in movimento, dinamizza, la stessa ideologia dello spazio espositivo e del display riproponendo una certa indifferenza per il posizionamento dell’opera che paradossalmente, partendo da fattori contestuali, rivaluta la propria mobilità rispetto ai contesti espositivi.
La parola latina tabula esprime bene questa doppia valenza di una orizzontalità/verticalità disposta ad accogliere e dimenticare i segni e l’essere anche una tavoletta, una tavola, un pianale. Superficie ricettiva e di
lavoro che richiama, in mostra, le opere di Carlo Guaita, non soltanto per una certa disponibilità a mutarne
le condizioni espositive che ho sempre ravvisato nei suoi allestimenti, ma anche poiché le sue immagini
sono tavole nelle molte accezioni della parola italiana: illustrazione, supporto dell’icona, tabella degli elementi
(tavola periodica), piano di lavoro, etc.
Guaita è un esempio di come l’astrazione, dopo l’iconico, abbia anche una sua relazione iconografica, che
nelle sue opere si fa visione del mondo (astratta o figurativa, pur sempre dialetticamente storica) e di come
la pittura sia ormai inclusa in un territorio più vasto di operatività.
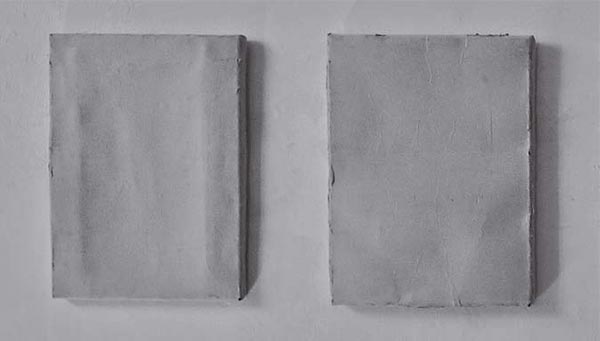
Carlo Guaita, Senza titolo (Fantasmi), 2013, cartone, cm. 40x35 cm. (6 parti), dettaglio
Lapis
Nonostante l’appello all’intermedialità e all’ibridazione dei media possa indurre a pensare in termini di novità
e di innovazione tecnologica quanto sulla pittura astratta si è detto sinora, credo invece che sia in una
antica e indissolubile parentela come quella col disegno che si colgano molte delle considerazioni appena
scritte. La relazione tra la pittura ed il disegno è oggi profondamente mutata pur essendo rimasto quasi
intatto il rapporto di progettualità che il secondo rivestiva per la prima. In un certo qual senso il disegno e il
suo strumento, la lapis haematitas, è divenuto con un riavvicinamento etimologico al significato di pietra, la
geologia del quadro. Intendo dire che il disegno sta ora agendo in senso stratigrafico e non più compositivo,
prospettico o chiaroscurale. Esso possiede uno scopo generativo diverso, nel senso che traccia il quadro, lo
sostanzia attraverso la sovrapposizione degli strati, del tratto, delle discontinuità tra sfondo e segno.
Questa potenzialità del disegno in relazione alla pittura era stata già intuita, con scopi poetici di altra natura,
da Alighiero Boetti negli anni settanta quando, dopo l’enfasi sui materiali della prima stagione poverista,
si era avvicinato alla parca ed effettivamente povera strumentazione del foglio e della matita. Cominciando
ad indagare una sistematicità assurda o, se si vuole, l’assurdità e irrazionalità dei sistemi, Boetti
aveva affidato ai visitatori volenterosi del suo studio il compito di campire le sue tele col tratto minuto della
biro, ottenendo per scala e intensità un effetto assolutamente pittorico, attraverso un’idea di atelier occasionale.
Tale tratto di biro ha, inevitabilmente, la sua stretta parentela con le “mappe” da lui fatte realizzare
in Afghanistan, pianali anch’essi, animati dalla trama tessile delle tappezzerie.
La geologia del disegno chiama dunque in causa ciò che sinora si è detto circa il solco, l’intermedialità e il
pianale, nel senso che più che definire i contorni o la specificità ne rappresenta uno stadio di leggibilità, in
cui si comprende bene la versatilità della superficie pittorica, il suo rapporto con i “solchi” che la costituiscono
e, soprattutto, quanto il termine “intermediale” sia distante da quello di “multimediale”.
Tuttavia tale apparente semplicità è solo un punto di partenza come dimostra l’opera di Ignacio Uriarte che
ha esplorato ed esteso, a mio parere, questo rapporto fra disegno e pittura in molti altri mezzi e latitudini.
Oltrepassando alcuni sentieri già battuti dal Modernismo, come la ripetitività anti-compositiva dei pattern,
Uriarte ha svelato come pittura e disegno possano nascere sovrappensiero, privi di logica ma colmi di causa
efficiente e materiale, come una parete rocciosa. La pittura come routine, come manifestazione illogica e
primordiale, come intrattenimento del tempo in sé stesso – e non dello spettatore – è un suggerimento che
nasce, appunto, dall’adottare dei sistemi generativi geologici.
note
1 Un libro di attenta lettura ed un ottimo atlante del fenomeno postmoderno è: I. Sandler, Art of the Postmodern Era. From the late 1960s to the early 1990s, New York, IconEditions, 1996.
2 W.J.T. Mitchell, Iconology. Image, Text, Ideology, Chicago e Londra, The University of Chicago Press, 1986, pp. 95-115.
3 R. Krauss, Note sull’indice, parte II, in Id., L’originalità dell’avanguardia e altri miti modernisti, Roma, Fazi Editore, 2006, p. 225. Ivi, p. 228.
5 Devo queste argomentazioni all’utilissimo e brillante articolo di: J. Elkins, Cosa può dire la teoria peirciana del segno alla storia dell’arte?, in «E|C Rivista on-line dell’AISS», 20 marzo 2008. http://www.ec-aiss.it/archivio/tipologico/autore.php
6 E. de Chassey, Callum Innes, in Callum Innes: From memory, a cura di F. Brad ley-E. McLean, Edimburgo, Hatje Cantz e Fruitful Gallery, 2006. http://www.calluminnes.com/media/eric_de_chassey__from_memory_text.pdf
7 G. Boehm, La svolta iconica, Roma, Meltemi, 2009, p. 109.
8 J. Derrida , La différance, in Margini della filosofia, Torino, Einaudi, 1997, p. 37.
9 W.J.T. Mitchell, I media visuali non esistono, in Pictorial turn. Saggi di cultura visuale, Palermo, Duepunti edizioni, 2008, pp. 81-95.
10 Ivi, pp. 87-8.
11 L. Steinberg, Neodada e pop: il paradigma del «pianale», in Alle origini dell’opera d’arte contemporanea, a cura di G. Di Giac omo- C. Zambianchi, Roma-Bari, Laterza, 2008, pp. 95-138.
|

